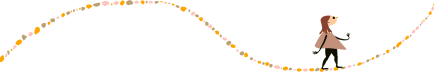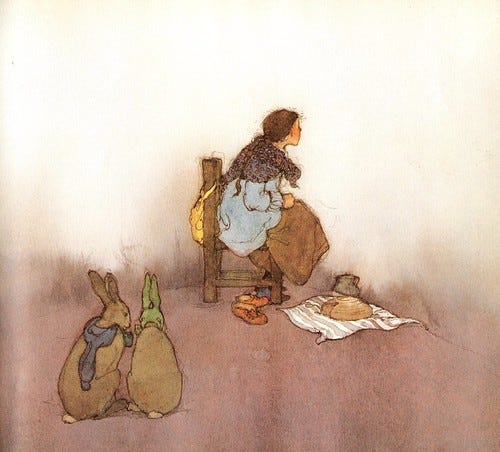Ho acceso la luce ed erano più di un centinaio.
Vorrei dire fossero in fila, come forse uno se le immagina, ma ad un primo colpo d’occhio, sembrava più che altro un caos ben organizzato. Le formiche andavano avanti e indietro sul davanzale del bagno, circumnavigavano la scatola dei fazzoletti, scendevano o scalavano il termosifone, per poi radunandosi a fiotti dietro al secchio per i pavimenti. Niente nel pomeriggio aveva fatto presagire l’avvento di una tale invasione. Ho quindi cercato di scovare qualcosa di commestibile che potesse giustificare una simile chiamata alle armi: niente, nemmeno la carcassa di una scolopendra o di un calabrone. Cosa stavano facendo tutte quelle formiche comparse dal nulla? Sono rimasta affascinata e ipnotizzata. Le ho osservate per quindici minuti buoni, cercando di indovinare il disegno delle loro traiettorie. Ogni tanto mi sembrava di scorgere un senso, una direzione in quel loro zigzagare caotico, ma appena una linea sinuosa pareva condurmi ad individuare una pista, ecco che due o tre formiche venivano a scombinare il quadro.
“Che si fa?” “Niente” ho risposto. “Così come sono venute se ne andranno”. Tomaso non era affatto convinto.
Tradizione vuole che appena compaiono formiche in casa, si inizi una lotta senza quartiere. Scopa, aspirapolvere, sale, e prodotti per disinfestare. A molti le formiche fanno senso, ad altri schifo. Certo, non al pari degli scarafaggi, ma poco ci manca. Si è certi che una volta arrivate non se ne andranno più via, che siano pronte e determinate a colonizzare la nostra cucina, il balcone, il bagno. Per altro l’idea di avere un’invasione di formiche si insinua in profondità e per giorni non si fa altro che pensare al “problema”. Io trovo le formiche affascinanti tanto quanto le api e vederle lì, andare su e giù per le piastrelle, tutte affaccendate a seguire qualche ignota ragione, mi ha subito suscitato ammirazione. Il fatto poi che fossero arrivate così all’improvviso, a centinaia... beh, doveva voler dire qualcosa. Un messaggio per noi? Stavano facendo pulizia? Una riunione segreta in un ben specificato “luogo energetico”? Tutto stava avvenendo di notte, in pieno silenzio; se non fossi scesa a fare pipì probabilmente non le avrei neanche viste. “Stiamo a vedere, che dici?” . Tomaso a malincuore ha acconsentito, forse più vinto dal sonno che convinto dall’idea. Sta di fatto che al mattino dopo erano tutte sparite. Tutte. Nemmeno una micro formica dietro al secchio dell’acqua che solo qualche ora prima aveva destato un così vivo interesse.
Ho pensato alle parole, al percorso che prendono nella nostra vita, come arrivano e come se ne vanno. Sono file o gruppi di suoni di cui ci sembra di cogliere il significato. Quante parole diciamo e perdiamo? Sono più quelle che dimentichiamo di aver detto o ascoltato di quelle che tratteniamo. Allora forse le storie servono a questo: a non dimenticare. Ma anche le storie si dimenticano, i libri letti, gli aneddoti famigliari, si perdono anche le parole con cui narriamo agli altri e a noi stessi i ricordi della nostra vita. A volte, di notte, all’improvviso, tra il sonno e la veglia, o fissando il soffitto in cerca di quel pensiero che ci cullerà, qualcosa riaffiora, un po’ come accendere la luce e trovarsi davanti a centinaia di formiche. Eppure anche quelle parole sono destinate a scomparire.
A volte rimuoviamo storie, parole e ricordi con pervicacia: armati di utili strumenti di distrazione, facciamo di tutto per dimenticare. Alcune parole per qualche tempo ci ossessionano, ma poi, per fortuna, dimentichiamo. Allora pensavo alle parole che restano con noi a lungo, splendenti e apparentemente innocue, un formicaio in giardino, sotto al pino o dietro la siepe, che ritrovi uguale anno dopo anno, più o meno attivo, ma se infili un bastoncino, ecco affiorare in superficie un nugolo di formiche.
Le parole che restano sono quelle dei riti. La fiaba è un rito. Ti può sembrare di averla dimenticata, ma appena le riascolti, tutta la memoria riaffiora intatta, improvvisamente sollecitata. E tu partecipi di quelle parole tue e non tue, un Noi di parole che si tramandano, più o meno uguali, dentro di te, fuori di te, intorno a te. Ti hanno preceduto e ti sopravvivranno. Tu le abiti, loro ti abitano. Una accanto all’altra, caotiche eppure ordinate, le puoi capire oppure no, poco importa. Loro, le parole dei riti e delle fiabe, continueranno a tracciare le loro traiettorie misteriose. Cosa sarà di noi se perderemo tutti i riti, queste meravigliose liturgie della parola? Sempre più soli e dimentichi, animali malati di scienza e ragione, senza più parole per dire e raccontare l’anima, impauriti nella notte buia, vicini gli uni agli altri senza riconoscerci.
Le formiche forse arrivano di notte per ricordarci che esiste un senso profondo che sgorga dalla terra, che si muove sulla scia di energie stellari. Le parole sono formiche, una comunità laboriosa di significati e misteri che ha costellazioni quasi sempre non intellegibili ma di cui abbiamo bisogno per raccontarci la notte.
Sai che puoi avere un mese di Sassolini in regalo se la consigli a tre persone che si iscrivono?
Dove ti portano oggi i Sassolini
In questa Sassolini troverai:
un articolo dedicato alla fiaba come patrimonio collettivo di una comunità narrante
la fiaba “La fanciulla di legno” registrata così come l’ho narrata a memoria, in regalo per te
un esercizio per imparare a raccontare una fiaba a memoria. Guarderai la casina della strega di Hansel e Gretel come non l’hai mai vista.
uno sconto esclusivo per il mio corso “Raccontami una fiaba”
Nella quiete l’ascolto
Non ci sono promesse di risultati tangibili e immediati nel raccontare le storie nel modo in cui mi sono allenata per anni. Anzi, il senso di togliere dal racconto orale ogni elemento performativo è proprio quello di poterlo riportare tra le persone come gesto quotidiano, con quella consuetudine e familiarità che lo ha caratterizzato nel tempo. Ho speranza che la parola possa tornare ad essere viatico di cura proprio quando non pretende di celebrare, rappresentare, risolvere o distrarre, ma piuttosto quando si propone di accompagnare, di starti accanto con la dolcezza di un rito.
Togliere dal racconto orale ogni elemento performativo significa abbracciare l’imperfezione di una narrazione a memoria che trovava e trova il suo fascino e la sua potenza nell’estemporaneità e nella spontaneità. Non siamo più abituati a ricevere una fiaba gratuitamente: c’è sempre qualche elemento extra-ordinario che sta intorno alla narrazione, mentre è la narrazione ad essere di per sé straordinaria, con il suo linguaggio semplice e al tempo stesso altro. Più si è nella quiete e nell’ordinario quando si narra, più si lascia la possibilità a chi ascolta di trovare la condizione ideale per una rêverie, ovvero un sogno ad occhi aperti e allo stesso tempo per coltivare “un’attenzione fervente”.
Rinunciando al momento perfetto, ad una pronuncia impeccabile, ai costumi, alle luci e ad ogni apparato scenografico, si può attraversare la fiaba recuperandone la capacità di essere contemporaneamente attuale e inattuale. La fiaba nel mio lavoro di ricerca è un filo intessuto nella trama dei giorni, un ordito quieto e quotidiano.
Il modello di riferimento quando narro è mia nonna. La sensazione che mi accompagna è il profumo del suo grembiule o della sua camicia da notte quando mi teneva vicina per raccontarmi La bella dai capelli d’oro. Quando mi raccontava le favole non cambiava voce, e quella voce stava nelle parole con una tale verità che tutto il racconto, e non meno quel momento d’amore, diventavano veri. Il modo in cui nonna Linda diceva le favole è ciò a cui io aspiro ogni volta che accendo la fiamma di un focolare e adulti e bambini si siedono intorno a me. Quando qualcuno si addormenta io sono la persona più felice del mondo.
E insieme alla quiete c’è una magia che mi coinvolge e al tempo stesso mi travalica: il palesarsi del mistero che le parole della fiaba sanno sempre portare a chi le ascolta senza avere il bisogno di interpretarle, con l’unico intento di abbandonarsi al suono di una voce.
***
Dire nascostamente
Le fiabe raccontano la vita nascostamente: esse celano, in un coinvolgente susseguirsi di vicende e azioni, la complessa metafora dell’esistenza umana. Dal 1800 in poi, da quando la fiaba è divenuta parte del lessico borghese e da quando, dai primi del ‘900, il linguaggio psicanalitico ha iniziato a far parte del pensiero comune, la grande metafora dell’esistenza che la fiaba incarna ha trovato molti ambiti in cui essere applicata.
Le fiabe specialmente negli ultimi trent’anni hanno risvegliato nel pubblico adulto, e in particolare in quello femminile, un nuovo interesse proprio a partire da ciò che esse avevano gelosamente custodito per molti secoli, ovvero il loro variegato sistema simbolico.
Potremmo definire i simboli come le essenze della metafore, condensati viventi e vitali che camuffano in parole e immagini significati più ampi.
Portare alla luce un tesoro nascosto è indubbiamente un compito affascinante, e a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso sono nati tutta una serie di studi, rappresentazioni e percorsi di cura che miravano alla riscoperta di un sé archetipico e al superamento delle proprie paure grazie alla fiaba.
Questo è quello che succede ancora oggi: si rinsalda il successo della “rivelazione metaforica” anche e soprattutto in virtù di questa attenzione al sé che non è mai stata così alta come dopo la pandemia, soprattutto grazie alla proliferazione di corsi e percorsi sui social volti a promuovere, tra le altre cose, un ritorno ad una natura ancestrale.
A chi sa leggerla, la fiaba mostra nitidamente i suoi punti cardinali: dal Nord di una situazione iniziale che perde la sua stabilità, si attraversa il bosco ad Ovest per giungere a Sud, agli inferi, con le sue dure prove, per poi risalire verso Est e la luce, ritrovando nuovamente il proprio Nord finalmente stabile, sicuro e duraturo.
Tuttavia il rischio è quello di credere che la potenza della fiaba stia proprio in ciò che si è riusciti finalmente a veder splendere alla luce del sole.
Nonostante le letture psicanalitiche e psicologiche del ‘900, e nonostante i documentati successi terapeutici ottenuti grazie all’apparato metaforico fiabesco, il mistero della fiaba resta intatto ed è di fatto tanto più nascosto quanto più si pensa di averlo infine disvelato.
Il punto è che forse oggi non si è interessati a comprendere questo aspetto del racconto popolare, preferendo fermarsi al potenziale terapeutico e interpretativo senza più badare o lasciarci sedurre da ciò che il mito e la fiaba continuano a dirci nascostamente.
Una cosa importante e forse un po' paradossale rispetto alla lettura psicanalitica, ma che gioca una parte non da poco nel preservare il mistero della fiaba, è che questa forma antica di racconto non ha mai, nel suo carattere narrativo, sfumature psicologiche.