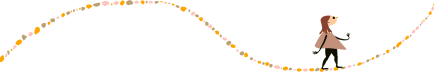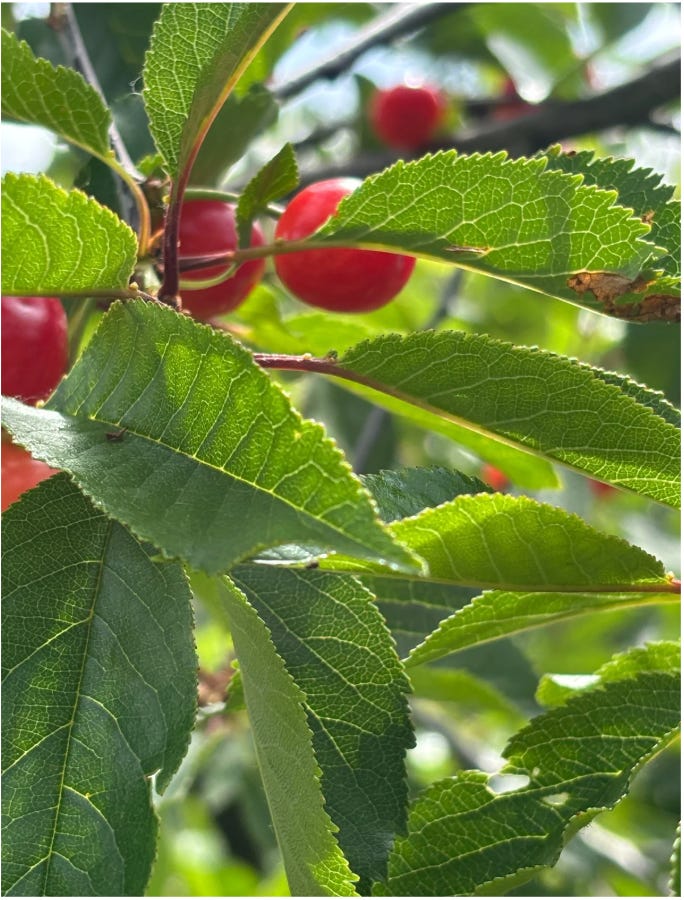Con voce bellissima ha letto
la prima pagina di uno dei suoi libri preferiti. La sua voce era bella perché autentica. Le riconosci subito queste voci: restano le stesse anche davanti a un pubblico.
Siamo al Festival Parolario di Como e la piccola platea davanti a noi è composta da adulti e ragazzi delle superiori.
G. legge ed è tutto dentro al libro: è chiaro che vorrebbe potessimo entrarci anche noi, sentire quello che lui sente.
Seguo l’esile trama di un incipit in prima persona, che più che dare l’abbrivio alla storia, butta sul foglio una serie di stati d’animo, tutti piuttosto cupi e malinconici.
G. gira pagina, è deciso ad arrivare fino al primo capoverso perché sa quanto occorre leggere prima di riuscire almeno ad intuire l’anima del protagonista. Non si tratta più di un romanzo o dei suoi personaggi, qui si tratta proprio di entrare nell’anima di... G.
Si potrebbe pensare al grande potere che ha un libro, il potere di farci parlare di noi, di sviscerare l’anima di ogni lettore. Molti gruppi di lettura muovono da questo intento e se poi il lettore è un ragazzo, e grazie al libro trova il modo di potersi raccontare, di approdare alle parole per esprimere i propri sentimenti, allora è probabile che l’adulto si riterrà soddisfatto di aver fornito una simile occasione di avvicinamento.
Siamo così spaventati dall’ineffabilità dei ragazzi, dalle loro inquietudini così irriducibilmente diverse dalle nostre, dal loro mondo segreto, che “farli parlare” ci sembra sempre una buona idea.
Ho provato grande commozione davanti a G, ma ho anche faticato molto a non intervenire, combattuta tra la curiosità di guardarlo prendersi il palco e il desiderio lancinante di proteggerlo. Stava facendo a tutti un dono troppo grande, e non ero certa che i presenti fossero davvero consapevoli di ciò che stava accadendo. La platea era distratta, quasi insofferente. L’attenzione è il privilegio più alto di cui possiamo godere, ma se è già difficile ottenerla da un interlocutore, figuriamoci da un intero pubblico.
G. immerso com’era nella lettura del suo libro preferito si è isolato ed ha cominciato ad abitare un tempo tutto suo: voleva leggere, si vedeva, e aveva bisogno di raccontarsi attraverso il libro.
So che G. fa parte di un gruppo di lettura che smonta il testo, lo analizza, lo setaccia in cerca dei meccanismi narrativi, i quali poi possono poi essere utilizzati dai ragazzi per scrivere a loro volta. Sono competenze molto sofisticate da acquisire, ed è bello pensare che c’è qualcuno che guarda agli adolescenti con tale fiducia: che possano far propri i testi, che riescano a padroneggiarli tanto bene da scrivere a loro volta in maniera efficace, precisa.
Tuttavia, mi piacerebbe che riuscissimo a investire i ragazzi anche di un’altra responsabilità: trovare nella letteratura il mondo, il resto, allontanarsi da sé con tutta l’innegabile fatica che questo comporta.
Perché il rischio di parlare di sé, ricondurre ogni cosa a sé, avvalorare il sé, scegliere quello che ci “risuona” è quello di trasformarci in campane in grado di rimandare solo un’unica nota: la nostra.
Mi piacerebbe tornare a parlare con questi ragazzi, riflettere con loro sull’Alterità della lettura, sull’immedesimazione che non è il rispecchiamento (anzi forse proprio il contrario) sul libro che ci legge e ci racconta cose che non fanno ancora parte della nostra esperienza, del libro che dona e va oltre il nostro perimetro per espandere il sentire del cuore.
Nel frattempo vi lascio con la seconda parte dell’articolo a loro dedicata.
Se vuoi recuperare l’articolo precedente, lo trovi qui.
La ragione della forma, i sentimenti dei contenuti
(…) La letteratura per ragazzi esiste ancora?
Esiste sì, ma è molto difficile non solo incontrarla, ma anche attraversarla. È successo qualcosa negli ultimi venticinque anni nel modo in cui i ragazzi approcciano l’editoria e la letteratura e ho come l’impressione che si sia formato un crepaccio tra la mia generazione e l’attuale, un crepaccio su cui è sempre più complicato gettare un ponte per agevolare il passaggio non solo dagli YA alla “letteratura per ragazzi” e alla letteratura in generale, ma anche tra due gesti solo apparentemente uguali: tra leggere e saper leggere (che non consiste a mio avviso nel saper capire i meccanismi di scrittura o nel saper parlare e argomentare intorno ad un libro).
Terremoti
Il primo terremoto si è registrato sulla scala della forma: come libraia non posso non notare che la letteratura per ragazzi ha un pentagramma molto ostico per le orecchie delle nuove generazioni.
Ma che cos’è la forma?
La forma non si può ridurre a come un testo è scritto (paratassi, ipotassi, stile, etc) ma è il respiro stesso del testo, quindi qualcosa che nella sua essenza rimane estremamente misterioso. Nel XIX secolo e nel XX secolo si respirava ad un ritmo diverso, e c’era più tempo. Si lavorava certo, e pure tanto, ma il tempo del non lavoro era un tempo che permetteva quiete, spazi vuoti, cortili, piazze; ci si incontrava e si parlava e lo si faceva un po’ con tutti. Non importa che tipo di relazione vi fosse tra le persone: c’era gente per strada, anziani al bar, sedie sulle soglie, balere, feste di paese, grida per le strade, telefonate chilometriche, telefoni a gettone, panchine, muretti... si stava lì e si parlava. Le parole hanno un ritmo, un tempo, e non ballano mai da sole. Le parole sono le prime note sul pentagramma della nostra lingua madre. Costruiamo il nostro ritmo su di esse, vi moduliamo le nostre cadenze, la sintassi dei nostri pensieri (e ogni cultura ha la sua). Essere immersi nelle parole allena il nostro orecchio.
Ma cosa c’entrano le parole con la letteratura?
Tutto.
Nessuno di noi arriva alle storie, e quindi ai libri, di punto in bianco. La comunità parlante e narrante, come la chiamo io, e nella quale siamo immersi fin dai nostri primi mesi di vita, è determinante per educare il nostro orecchio all’ascolto. Forse dimentichiamo troppo spesso che leggere è un gesto di ascolto. E non c’è persona più esposta ad apprendere il respiro del mondo di un bambino. Nasce, respira, parla.
Al libro come approdo “uditivo” arriviamo gradualmente passando per le parole parlate. Ed è chiaro che il ritmo di chi parla sarà diverso da quello di chi scrive e anche da quello di chi legge, ma le parole di una comunità hanno dei pentagrammi fatti di pause, di pieni, di vuoti, che insegnano agli essere umani una reciprocità fondamentale per mettersi in dialogo e quindi in relazione con il pensiero e il respiro di qualcuno diverso da noi, che non necessariamente racconta qualcosa che ci riguarda. Saper leggere è anche saper incontrare l’alterità e la prima alterità che ci offre la letteratura è la forma, il respiro di un testo che impariamo ad ascoltare prima ancora di arrivare ad immergervisi. E anche il libro, a sua volta, senza la necessità di essere per noi uno specchio, ci legge.
Accade ogni volta che incontriamo un’opera d’arte degna di questo nome: non Io che leggo il libro, Io che guardo il quadro, Io che ascolto la musica, ma il libro che mi legge, il quadro che mi guarda, la musica che mi ascolta.
Massimo Recalcati
La seconda scossa che ha formato il crepaccio tra la “letteratura per ragazzi” e i ragazzi è stata avvertita sulla scala dei contenuti. In letteratura la forma è il contenuto, quindi è chiaro che se il respiro del testo è più lento, anche i contenuti saranno dilatati, profondi, radicati ad un cuore che pulsa sangue e pensieri di altra fattura, di altro calibro.
Ma se la forma coincide con il contenuto, e la letteratura per ragazzi si è sempre prefissata di rendere piacevole, bello e interessante il passaggio alla letteratura per adulti, dovremmo ammettere che certe letture che pure annoveriamo come opere d’arte, non stanno superando il tempo.
Può un classico non essere più un classico?
Credo di sì e quello che lo fa lentamente decadere come se fosse una sorta di materiale radioattivo, è il suo grado di specificità.